Siamo tutti consapevoli che,
nelle ultime decadi, abbiamo dovuto fare i conti con il processo di
invecchiamento dei paladini del punk di epoche più o meno recenti; ma se è
relativamente semplice liquidare coloro che invecchiano con poco stile e non
crescono, più difficile è confrontarsi con i percorsi professionali e personali
dei pochi che, invece, sono diventati adulti. Le Sleater-Kinney, che del punk
incarnano tanto l’approccio Do It Yourself quanto la fierezza femminista meno
banale, tanto l’ingenuità del college rock sudista quanto la rivincita della
maturità artistica riscoperta, avevano legittimamente deciso di porre fine
all’esperienza dopo quel fuoco d’artificio di refrain appiccicosi e dissonanze
che fu The Woods; dieci anni dopo, la
nostalgia o forse il ritrovato tempo mentale e fisico spingono il trio a
incontrarsi ancora, per un successore purtroppo non ugualmente elettrizzante,
ma capace di difendersi sotto i colpi dell’età e delle insidiose nuove
generazioni. Low tuning è la parola d’ordine, non solo nelle chitarre ma anche
nella voce: Price Tag tenta un
attacco incontinente sulla falsariga di Lora Logic, senza però possederne
l’esasperazione; l’incipit condensa tutte le cifre peculiari del disco, che
segnano anche il volto meno glamorous e più riflessivo delle ragazze di
Olympia: le chitarre angolari combaciano secondo gli schemi del Tetris post
punk, senza però poter evitare un inguaribile afflato 90s, impastato di
melanconia, risentimento e tantazioni catchy. Loro malgrado, le Sleater-Kinney
a tratti scivolano negli anni zero, come in Fangless o in Bury Our Friends, trascinate da un claudicare chitarristico da
dancefloor in stile Arctic Monkeys o Franz Ferdinand, pivelli che le tre
signore potrebbero permettersi di sculacciare con le cinte delle loro sei
corde. I compatti cori hard glam di Surface Envy risvegliano la tensione, come a voler ricordare che
Suzie Quatro non fu da meno rispetto alle tante riot grrrl a venire e che le
frangette sono sempre sintomo di personalità; la title track e la successiva A
New Wave chiudono momentaneamente il
viaggio nei 70s per tornare ai più familiari territori della controllata
isteria pop wave, tra chitarre ora arabescate e riprodotte in serie, ora sature
e granulose. No Anthems è ancor
più destrutturata, grazie alla disinvolta malizia della voce divenuta
strisciante, prima di tornare alla consueta intenzione battagliera, liberata
poi nel campo minato di Gimme Love.
Le ragnatele chitarristiche di scuola Tom Verlaine vengono tirate a lucido in Hey
Darling; la schiva intelligenza dei
Television sembra ereditata anche nella confessione del ritornello (it
seems to me the only thing/ that comes from fame is mediocrity) in cui, nonostante l’insolita serenità, Corin Tucker
sembra voler aprire una finestra sulle ragioni della decade di silenzio e sulle
perplessità e difficoltà relative
al ruolo delle donne nel rock. Forse proprio per cimentarsi con gli
stilemi espressivi di certo machismo hard, la conclusione del lavoro è affidata
ai vocalizzi articolati e all’epicità di Fade: radicali senza piombare nel clichè, non celano di
essere donne e madri che sopravvivono tra la fine del capitalismo e l’agonia
dello stereotipo maschile del rock stardom. No Cities to Love è incollato alla vita reale, di cui offre una
narrazione eccellente spiccatamente americana: in questo senso è un disco folk,
alla stregua di Springsteen o dei Creedence, di cui condivide l’assennatezza
degli intenti e la scelta stilistica del vuoto intorno ai pochi suoni, per
mettere al centro il grande racconto.
Voto:
Label: Sub Pop


 14:20
14:20
 Angie BacktoMono
Angie BacktoMono



.jpg)








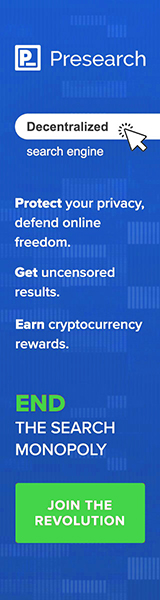
0 comments:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.