Il fatto che il post-punk sia
stato la soundtrack inattuale dei miei pomeriggi adolescenziali, consumati
seduta sul pavimento con la schiena contro il poster dei Joy Division appeso
proprio lì, alla porta della mia stanza, non aiuta a valutare con sufficiente
distacco un lavoro per molti aspetti “retromane” quale quello delle Savages:
perché alla fame di assorbire quel suono insieme muscolare e scarno ancora una
volta, e sentirlo uscire da corpi e cervelli non prematuramente deceduti o non
infiacchiti dal tempo, si affianca un’infantile diffidenza, verso epigoni che
il pregiudizio ha già tacciato di inferiorità rispetto agli eroi inetti del
secolo trascorso.
Così, la caustica frenesia che
erompe dalle prime note di "Shut Up"
provoca l’ambivalente effetto di una godibile familiarità e di una risentita
indignazione. Il basso circolare e melodico che arricchisce la ritmica
asciutta, la chitarra affilata ed essenziale e una vocalità intenzionalmente
teatrale fino all’eccesso: la riproduzione degli stilemi è ineccepibile, ma si
insinua il sospetto che manchi quella sensazione di sconfitta esistenziale,
coscientemente caricata sulle spalle, quale basilare movente espressivo. "I
Am Here" replica la nervosa desolazione dei
Bauhaus di "In The Flat Field",
incastrando intervalli di sgomento strumentale, che abbandonano sola la voce
singhiozzante di Jehnny Beth, in una tensione satura sino all’esasperazione. La
danza epilettica di "City’s Full" è
sorretta da una chitarra irrobustita, che si carica di overdrive in "Strife, ballad"
avvelenata e sfilacciata in una dilatazione epica. La batteria bidimensionale
introduce il soliloquio drammatico di "Waiting For A Sign": un’operazione di sottrazione sonora e
scarnificazione degli elementi qui stratificati, memore delle esemplari
intuizioni di Martin Hannett in fase di produzione, avrebbe forse accresciuto
il fascino lugubre e il senso di impotente rassegnazione, qui lasciati
inespressi.
Dopo il superfluo intermezzo
strumentale di "Dead Nature", succedersi
di rintocchi e gocciolii, il tentativo di aggressione si rinvigorisce con la
scheletrica poeticità del singolo "She Wil"l: sull’essenziale arabesco della chitarra Jehnny Beth riesce a
contenere la voce in una declamazione sofferta ma equilibrata, che deraglia
solo nel finale in uno strozzato singulto. Lo scatto febbrile di "No
Face" prelude all’accelerazione
incontrollata di "Hit Me", prima
del prevedibile epilogo segnato dall’inquieta "Husbands" e dalla premeditata drammaticità della title track,
che nemmeno il conclusivo sassofono discontinuo riesce a preservare da
un’impressione di prevedibilità.
Voto:
Label: Matador/Pop Noir


 11:13
11:13
 Angie BacktoMono
Angie BacktoMono













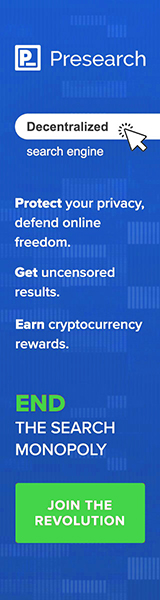
0 comments:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.