 Quello di Beirut è propriamente un ritorno, più che nel senso meramente mediatico, in quello greco del termine. Quello di Beirut è un nostòs, un ritorno nostalgico a casa, a riprendere a passeggiare per le proprie vie, con le proprie abitudini (anche se le vie e le abitudini in questione ricordano un po’ il fantastico burtoniano di Big Fish che quello di un giovane di Santa Fe). Questo è The Rip Tide, il vortice.
Quello di Beirut è propriamente un ritorno, più che nel senso meramente mediatico, in quello greco del termine. Quello di Beirut è un nostòs, un ritorno nostalgico a casa, a riprendere a passeggiare per le proprie vie, con le proprie abitudini (anche se le vie e le abitudini in questione ricordano un po’ il fantastico burtoniano di Big Fish che quello di un giovane di Santa Fe). Questo è The Rip Tide, il vortice.
Lo stavano aspettando in molti, ed anche con una certa ansia. Anticipato dallo splendido EP East Harlem (e dalla b-side Goshen) buttato lì durante l’estate, era dall’inverno scorso che aspettava di essere battezzato alla luce del sole e dei fan. Qualche ritardo e smania da globetrotter ci sono state, sì, ma ora il disco ce lo abbiamo fra le mani. Che Zach Condon sia riuscito ad affermarsi come uno dei rappresentanti del mondo musicale indie è certamente un fatto se non merito obiettivamente riconosciuto. È uno che ha fatto della sua sensibilità a sonorità folkloristiche di ogni angolo del mondo un marchio indistinguibile del suo lavoro di artista, senza essere mai pesante né scontato. Ammettiamolo: portare alla ribalta il balkan sound non è proprio facile. Mettersi a maneggiare mandolino e tromba, farci un pezzo senza rischiare di scendere di livello è veramente difficile.
Cosa dire di quest’ultimo lavoro? Il vortice di fisarmoniche, liuti, trombe si immergono in andanti giri di piano che scandisce stavolta forse con più incisione che nei precedenti album la cadenza di ogni track. Il musicante apre con A Candle’s Fire, attacca con una fisarmonica intrigante e procede tamburellando un ritmo da marcia, alternando percussioni varie e un corde leggere in sottofondo: si, lo stile è decisamente questo, ma è la presa che è diversa. The Rip Tide stessa è il sound di Condon che segue le sue mani sui tasti e si adegua al tutto: eppur sono solo quattro versi che tornano, e ritornano, e ritornano ancora – avete presente il Bolero? La sensazione è decisamente la stessa. Ah beh, poi aggiungete una voce che pochi hanno: forte e armoniosa.
And this is the house where I could be unknown again. Quest’album canta di casa ( Santa Fe ) e di anime viandanti ( lui, Vagabond ). Per quanto Santa Fe ricordi un po’ le sonorità killersiane dei loro pezzi più esuberanti ( ma anche più intimi, e così vale anche per Beirut ), non c’è paragone che regga. Beirut non ha decisamente parecchi termini di paragone, e il suo ultimo lavoro si arricchisce di un altro elemento, che è il suo mondo personale. L’orchestra risonante del timbro balcanico ha smesso di rimbombare e ha perso il suo lato carnevalesco : la vera festa è quella intima di Condon, quella in cui è solo e pensa ai suoi luoghi, adattandoci il suo estro artistico. Se c’è qualcosa che ritorna sempre, è la parola alone. Il tono intimo è quello di Goshen, ballata dolce ed un po’ romanzata, quello nostalgico è di Payne’s Bay, con quell’intro un po’ tragica e mazurkata: una realtà dimenticata e sognata, più docile del solito calderone scoppiettante di popoli, un po’ come una balera di fine serata. A chiudere questo eterno ritorno a casa è Port Of Call, tintinnata un po’ come una magia che svanisce innanzi agli occhi, per poi riprendere il motivo di The Rip Tide, col tono di fine di un epoca, appunto, la fine di un album.
Voto: ◆◆◆◆◇
Label: Pompeii Records


 15:00
15:00
 Marzia Picciano
Marzia Picciano












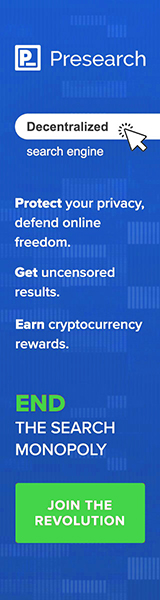
0 comments:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.