Se prestassimo fede alle
leggende, dovremmo accogliere Commune e
i suoi artefici come l’ultima incarnazione di un collettivo musicale attivo da
oltre vent’anni e misteriosamente ubicato a Korpilombolo, piccolo villaggio
svedese dove è ancora praticato il voodoo; e poiché la magia funziona meglio se
si è convinti della sua efficacia, asseconderò i miti e considererò la nuova
opera dei Goat come il secondo volume di un trattato esoterico.
L’esordio World Music, nella sua rievocazione iperdinamica tanto del
primitivismo del Pop Group quanto delle suggestioni conturbanti degli
Organisation, induceva negli ascoltatori uno stato di invasamento costante
portando a una dipendenza pervicace; quasi asfissiante con la sua giungla
sonora, lasciava stremati come dopo una danza catartica. Attesi alla verifica
della seconda prova, i Goat di Commune affilano le lance e scolpiscono i loro totem con più accuratezza: Talk
to God scandisce percussioni e arpeggi con
la pazienza di chi attraversa le decadi come fossero una manciata di istanti e
apre subito questo secondo capitolo con tribalismi di exotica Sixties, non
quella patinata di Les Baxter ma quella bizzarra e inquietante di gruppi
misconosciuti inghiottiti dall’oblio degli anni. L’incipit si chiude con l’insistenza
del basso preludendo a Words e al
suo assolo isterico e intermittente, riflesso lontano delle incursioni
lucidamente sanguinarie di Fripp nei primi dischi di Eno; del dittico Here
Come the Warm Jets e Taking Tiger
Mountain by Strategy , insuperabile
amplesso di audacia furente e sperimentazione scientifica, Commune condivide la tensione verso una sintesi postmoderna
del primitivo. The Light Within è
un’ipotesi impossibile di come sarebbero i tropici se transitassero verso nord
attraverso i paralleli; il collettivo incastra poi saggiamente To
Travel the Path Unknown, parentesi assopita
tra campanelli e arpeggi lunari, prima di tornare con la perentoria cavalcata
Seventies di Goatchild, in cui si
innesta prepotente un’ancestrale voce maschile. “The spiritual is
more real than most of us believe”,
esordisce il predicatore in Goatslaves: nel frenetico dancefloor la negritudine è prosciugata fino a un funk
segnatamente europeo nella ritmica bidimensionale, dove è il basso a segnare
risoluto le tappe della marcia. Il singolo Hide from the Sun apre con un riff che rischia di essere epico ma, per
buona sorte, si risolve in volute memori di Ananda Shankar; una distorsione
poco invadente contamina il pezzo proprio al centro prima di tornare, in una
perfetta ciclicità ancestrale, al riff iniziale diventato ora acustico.
Incrinato a metà è anche Bondye:
dalla ripetizione di scampanii e asciutti colpi di gong sintetici si inceppa
per virare in un’accelerata orchestrazione da opera cinese, profanata
dall’ennesimo assolo frippiano. Gathering of Ancient Tribes, con il suo cantato rabbioso oltre il selvaggio,
annuncia che la natura è feroce e l’uomo che la evoca nel rituale animista non
può essere da meno; disperata e rovente è anche la coda chitarristica finale,
quasi un urlo lancinante di un animale in via d’estinzione.
Voto: ◆◆◆◆◇
Label: Sub Pop


 11:02
11:02
 Angie BacktoMono
Angie BacktoMono













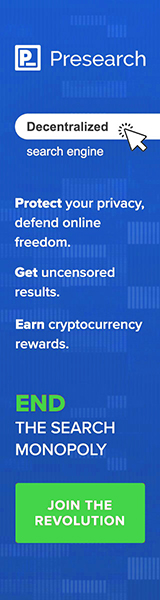
0 comments:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.