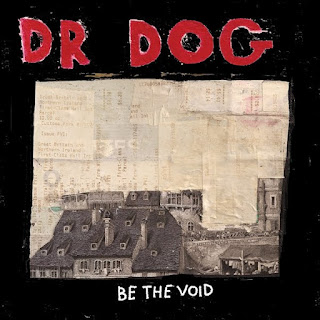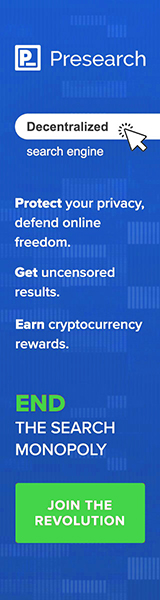Voina Hen (2011), opera prima dell'omonimo quintetto post-grunge di Lanciano. Basterebbe dare un'occhiata all'artwork della copertina del CD - opera di Nicola Maria Salerno - per coglierne il senso: una donna con le gambe costrette in un cerchio e il volto schiacciato verso il basso, la cui vagina si allunga mostruosa nelle sembianze sinistre di un pozzo petrolifero in funzione. Tutto questo è un concentrato potentissimo di tematiche care a Bukowski, abbracciate e attualizzate efficacemente dall'album. La denuncia rabbiosa e rassegnata degli orrori post-fordisti («sensazioni di petrolio/ che vengono via dal tubo catodico/ annusi la follia della tua civiltà/ ma non puoi più fuggire», Sensazioni di petrolio), il rifiuto lucido e il rovesciamento a gambe all'aria dell'amore romantico come balsamo consolatorio («professo la mia totale depravazione assoluta/ io non ho mai amato nessuno/ e mai lo farò/ ho bisogno di distruggere qualcosa di bello/ di infangare la tua pelle», Grid), il nichilismo più gelido che cerca rifugio nel calore liquido e mortifero dell'alcool («ci scontravamo nei bar/ danzando verso l'abisso/ il bere attenuava la nostra sconfitta/ annebbiati dal grande gin/ ci affrontavamo nei vicoli/ ed era storto e crudele il mondo/ crudele quanto noi verso di lui», Charles - di certo non il Baudelaire dell'énivrez-vous creativo, già asservito al pop da Stereolab e, in casa nostra, Baustelle)...
Voina Hen (2011), opera prima dell'omonimo quintetto post-grunge di Lanciano. Basterebbe dare un'occhiata all'artwork della copertina del CD - opera di Nicola Maria Salerno - per coglierne il senso: una donna con le gambe costrette in un cerchio e il volto schiacciato verso il basso, la cui vagina si allunga mostruosa nelle sembianze sinistre di un pozzo petrolifero in funzione. Tutto questo è un concentrato potentissimo di tematiche care a Bukowski, abbracciate e attualizzate efficacemente dall'album. La denuncia rabbiosa e rassegnata degli orrori post-fordisti («sensazioni di petrolio/ che vengono via dal tubo catodico/ annusi la follia della tua civiltà/ ma non puoi più fuggire», Sensazioni di petrolio), il rifiuto lucido e il rovesciamento a gambe all'aria dell'amore romantico come balsamo consolatorio («professo la mia totale depravazione assoluta/ io non ho mai amato nessuno/ e mai lo farò/ ho bisogno di distruggere qualcosa di bello/ di infangare la tua pelle», Grid), il nichilismo più gelido che cerca rifugio nel calore liquido e mortifero dell'alcool («ci scontravamo nei bar/ danzando verso l'abisso/ il bere attenuava la nostra sconfitta/ annebbiati dal grande gin/ ci affrontavamo nei vicoli/ ed era storto e crudele il mondo/ crudele quanto noi verso di lui», Charles - di certo non il Baudelaire dell'énivrez-vous creativo, già asservito al pop da Stereolab e, in casa nostra, Baustelle)...Un concept album dedicato alla dottrina del sedicente «vecchio porco», esasperatamente sessista e politically uncorrect per amor di soldo, dunque? Certo che no; oltretutto la chiusura del lavoro, nel brano "Non avremmo dovuto", è affidata ai versi - recitati da Vittorio Gassman - di "Alla mia nazione" (La religione del mio tempo, 1961) di Pasolini.
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti,
tra case coloniali scrostate ormai come chiese.
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. [...]
Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.
Quanto di più lontano dal disfattismo individualista bukowskiano? I Voina sono giovani, questo è il punto; la loro è un'iconoclastia infuocata, carnale, che contraddice lo stesso slancio di autodistruzione veicolato dai testi. I loro non sono i ricordi rielaborati a distanza da un vecchio misantropo col dono della penna. I Voina Hen sono pulsione sessuale in atto. La scarnezza virile del suono, che attraversa massiccia una per una le nove canzoni, è un vestito che ben si adatta all'essenzialità diretta delle liriche. Il loro primo album, per quanto fin troppo omogeneo negli arrangiamenti, è una prova più che dignitosa di onestà intellettuale e riflessione creativa.
Voto: ◆◆◆◇◇
Autoproduzione


 13:27
13:27
 Silvia Di Qualcosa
Silvia Di Qualcosa