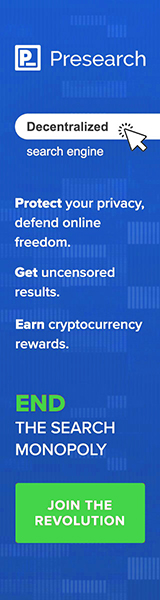Siamo umani, dopotutto. Questo
statement racchiudeva
in sè quello che sarebbe successo otto anni dopo, ma d’altronde allora
nessuno li prese veramente sul serio, e invece è successo: i
robot parigini noti come Daft Punk sono diventati esseri umani, sono tornati dal loro pianeta
Interstella 5555 e hanno realizzato che, tutto sommato, l’elettronica può venire umanizzata attraverso ritmi caldi ed estremamente
catchy, figli di un tempo e di un suono perduto che si pone lì dove tutto è cominciato, nella
disco music, quella più ruffiana e
per tutti. Questo processo viene espresso in modo particolarmente chiaro attraverso la storia degli
incipit dei loro dischi: laddove
Homework, figlio di una estetica anni ’90, manifestava sperimentazione, i primi secondi di
One more time (Discovery, 2001) lanciavano il sound
french touch verso le classifiche mondiali della musica
house, quella più raffinata,
catchy e anche, come si suol dire oggi per identificare un certo tipo di musica
EDM ovvero
Electronic Dance Music, che fa tanto figo.
Human after all, 2005, partiva
con dei rintocchi di drum machine, il che, applicato al titolo
dell’album, presentava una denuncia, una accettazione e una riflessione
sull’ibridazione delle forme fisiche del
rock e
elettroniche,
un tema caro a molti, moltissimi, ma che rappresentava, musicalmente,
una chiara dichiarazione d’intenti. Inutile parlare delle O.S.T. e del
resto, che alla fin fine conta poco.
Ora prendete questi tre lavori e
metteteli da parte perchè la creatura Daft Punk oggi è qualcosa di nuovo, completamente diverso, che taglia nettamente i ponti con il passato e che fa
tabula rasa di tutto quello che
Fu il
french touch, da loro stessi creato, evoluto e concluso. Cosa è accaduto in questi 8 anni? Tutto e niente. Raccolte, un disco live,
Alive, dieci anni dopo lo storico
Alive 1997, la firma per la colonna sonora di
Tron, a sua volta rifacimento dell’omonimo originale del 1982, molto meno sperimentale del primo ma molto più
figo, e poi un suo
remix, una sua ricostruzione. Queste
release
vogliono dire tutto e niente perchè qualcosa di tangibile è stentato ad
arrivare. Quel qualcosa è stato anticipato da una grandissima campagna
mediatica, di fronte alla quale
Trent Reznor potrebbe addirittura impallidire, che ha costruito dibattiti e titoli di
Disco dell’anno a qualcosa che non aveva ancora una sua natura, del quale nessuno aveva alcuna idea. Questo
hype,
questa strategia, si è espressa in maniera completamente differente
rispetto ai loro lavori passati in quanto mossa da scopi differenti. I
Fu Daft Punk erano caratterizzati da un grande rifiuto della ricerca della forma popolare e in generale hanno sempre
dato l’impressione
di vivere su quel loro pianeta che gli ha dato tanto successo. I loro
concerti, le loro interviste, la loro presentazione dietro delle
maschere, le stesse copertine degli album (sempre incentrate
semplicemente sul loro
logo)
hanno alimentato nei fan
un modo di vedere questa realtà così amena dal mondo elettronico e dalle
sue tendenze, una realtà allo stesso tempo così vicina e così lontana
dagli sviluppi della musica. Questo è, in breve, il
Fu. Qualche
giorno fa (ho perso il conto, sembra ormai di conoscere l’album da una
vita) è uscita la notizia che il disco è stato pubblicato gratuitamente
per qualche giorno, poichè la data di uscita è il 21 maggio del mese
corrente, e lì molti di noi, fan del duo, hanno
schiacciato play. Per quanto il singolo
Get lucky, con la partecipazione di Pharrell, abbia proposto un suono molto diverso dal solito, molto
disco, legato a una personalità come Giorgio Moroder, ma non solo, credo che non tutti si aspettassero che
Give life back to music fosse, ancor prima che musicalmente, la soluzione dell’enigma della sfinge di
Human after all,
perchè il passaggio dall’album precedente a quello attuale è ancor più
estremizzato di quello intercorso, non a caso, nei francesi
Justice da
Cross a
Audio video disco. Il fine ultimo di questo disco è quello di riportare la musica elettronica alla vita, a quella indubbia
fisicità che ancora viveva all’interno dell’epoca della
disco, in quel periodo di transizione verso tutto quello che verrà in seguito.
L’
opener, così spiazzante, dopo un brevissimo motivo, quasi come se fosse una colonna sonora, lascia il posto ad un
sound
completamente inesplorato dal duo e completamente differente da tutto
quello che è stato composto da loro fino a quel momento. Gli elementi
principali che accompagneranno i tredici brani e che trovano nell’
opener una delle loro
summae sono un impianto
disco, una voce
vocoderizzata (ma completamente diversa rispetto al passato) e, in generale, un suono
soft e
dolce, che più volte strizza l’0cchio al
mainstream
e che smussa via tutte le asperità che possono essere di difficile
comprensione per garantire all’ascoltatore esteticamente la migliore
frutta possibile. Andando avanti con i brani ci si rende ben presto
conto che questo album, che taglia i ponti con la musica elettronica, è
basato, per la sua maggior parte, sugli ospiti che lo abitano, ospiti di
grandissimo rilievo nel panorama della musica moderna (e non). Cosa
dire al proposito della partecipazione di
Nile Rodgers degli
Chic, storica formazione
disco, o del Maestro del genere
Giorgio Moroder, nonchè di
Julian Casablancas dei
The strokes, del sopra citato
Pharrell Williams, di
Todd Edwards, di
Panda Bear (degli
Animal collective) e
di
Dj Falcon? Un cast d’eccezzione per un film d’eccezzione. Nell’idea
del duo c’è il recupero di certe sonorità come antidoto all’imperante
dominio delle
macchine elettroniche, che però costituiscono il pro (e il contro, per alcuni?) di questa musica. E quindi, andando avanti nell’ascolto, dopo la
ballad The game of love, arriva il tanto atteso brano
Giorgio by Moroder, dove, in un monologo, il Maestro della
disco afferma che il sintetizzatore rappresentò, sul finire degli anni ’60 e sul principio dei ’70, la quintessenza del
sound del futuro, quale poi si è rivelato, lasciando poi spazio ad un
divertissement
della vecchia scuola che incorpora un pò tutto, dalla vecchia
elettronica all’utilizzo di strumenti fisici, quasi a voler operare una
cannibalizzazione dei primi
Kraftwerk riletti attraverso una ottica
mainstream, mediata dalla
disco,
il comun denominatore di questo lavoro, cesellando un brano senz’altro
interessante ma che non fa gridare al miracolo e che soprattutto ha poco
o nulla dei Daft Punk, è piuttosto un brano di
Moroder. Al contrario
brani come
Within e
Instant crash, quest’ultima con alla voce
Julian Casablancas, sono dei brani
pop di qualità, ma non di musica elettronica, che avrebbero potuto essere composti da un qualunque ottimo musicista pop.
Lose yourself to dance è
invece un inno per le classifiche di musica colta e allo stesso tempo
scanzonata, guidata da
Pharrell, musicista che gode oggi di un
grandissimo successo (e che ora, alla luce di questo disco, lo
incrementerà moltissimo).
Touch, con
Paul Williams, fa leva
sulla figura cinematografica dell’ospite per consegnare un brano
fortemente teatrale, figlio del palcoscenico, che dopo una introduzione
sperimentale ma non troppo sfocia nella classica
disco che sta alla base di
quasi tutti i brani del lavoro. Segue quindi
Get lucky il primo singolo, che ripresenta
Pharrell Williams alla voce, convocato qui allo scopo di sfidare i
dancefloor più
fighi, e che sta riuscendo magistralmente nello scopo, insistendo, in questa
studio version, sulla ripetizione ossessiva, al limite delle peggiori pubblicità statunitensi, sul ritornello, maledettamente melodico e
catchy.
Beyond non aggiunge molto ad una formula già espressa in molti altri brani, se non fosse per la
reprise dell’introduzione cinematografica, stavolta figlia diretta delle presentazioni
Metro Goldwin Mayer.
Motherboard è
uno dei pochissimi episodi, stavolta trattasi di una strumentale, che
rimanda in parte ad alcuni brani molto melodici prodotti dal duo
nell’epoca
Discovery / Human after all, ma che suona, volente o
nolente, più stanco, un intermezzo che lascia poi posto ai brani
conclusivi, di ben altra portata, quali
Fragments of time, con
Todd Edwards, un brano estremamente pop e
catchy così come la successiva
Doin’ it right
con
Panda Bear. La conclusione viene invece affidata ad una delle
collaborazioni più importanti e di natura più elettronica, ovvero quella
di
Dj Falcon per
Contact, che suona come una coda che recupera ritmi antichi, ma sempre in una nuovissima ottica melodica e
catchy,
per sfociare poi in un suono che si alza verso un luogo imprecisato.
Sebbene occorrano molti ascolti per comprendere un disco come questo, si
possono fare due considerazioni. La prima è che, come disco dei
Daft
Punk, questo lavoro sia completamente distruttivo di tutto quello che
in passato i Nostri sono stati, e pertanto meriterebbe una bocciatura
secca, la seconda è che, se non fosse un loro disco, sarebbe un prodotto
piuttosto interessante. Una via di mezzo avrebbe potuto essere un
side project, ma non si può avere tutto dalla vita, per cui verranno date due votazioni differenti.
Voto Daft Punk:
◆◆◇◇◇
Voto Disco:
◆◆◆◆◇
Label: Columbia records


 11:50
11:50
 Max Sannella
Max Sannella