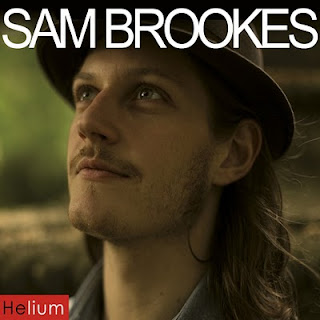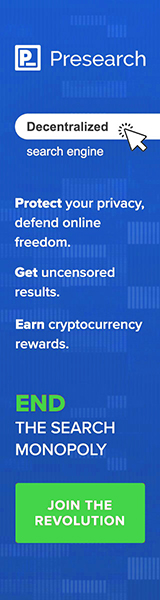Swing, freschezza mentolata ed un’infinità di spiragli stilistici che fanno una continua “festa mobile”, un disco questo “Buon giorno disse il metronotte” del trio torinese Banda Fratelli che gattona sagace e canaglia come una guida notturna a tutta velocità sulle autostrade dell’autoironia e delle intuizioni cool.
Swing, freschezza mentolata ed un’infinità di spiragli stilistici che fanno una continua “festa mobile”, un disco questo “Buon giorno disse il metronotte” del trio torinese Banda Fratelli che gattona sagace e canaglia come una guida notturna a tutta velocità sulle autostrade dell’autoironia e delle intuizioni cool. Una mirabile prova d’autore che mostra la capacità unica di costruire brani sempre diversi gli uni dagli altri, senza chiudersi in un’enclave o apparire snob, un cilindro magico che la band usa in un piacimento anomalo, con pochi trucchi e nessun inganno, con la sola forza di una verve sonica e poetica che si consuma nello spirito sano di una prova discografica da dieci e lode.
Con la scaltrezza scalena versione “educanda” alla Elio e le Storie Tese, Sergio Caputo, i vecchi Gufi e il Signor G “Buongiorno, disse il metronotte” come soprammobili voodoo di magia bianca, la band mette a segno questo disco che mira dritto, in un certo modo, alla tradizione cabarettistica, quella tra l’intellettualismo impomatato Dapportiano e la modernità profusa delle tirate scavezzacollo di Paolo Belli, dieci tracce che fanno scroller tra pompate di fiati, esotici ritmi d’avanspettacolo, un pizzicorio del Moroder broadwayano da colonna sonora anni settanta “Salsa e meringhe”, lo spaghetto western tex-mex travestito da ballata dondolante “Un fratello come me”, lo scatting-funk jazzato “E’ grave” e il tremolo latin sausalito svita-anche che danza conturbante e lussurioso tra i giri armonici di “Non so dir di no”.
Andrea Bertollotti chitarra e voce, Matteo Bonavia basso e Carlo Banchio cajon, sono i tre piloti sconnessi che raccontano storie, favole ironiche e realtà tragicomiche, tutte condensate amorevolmente in questo lotto godibilissimo di musica e movimenti in tre quarti, quasi un cartoon di plastica che gira invece di sfogliarsi, specie nella uacciueriua felix-story di un gatto invulnerabile nella sua domestichezza “Trippa per gatti” o nella meditabonda intimità guascona di “Le cose da salvare” traccia che con le mani in tasca e la testa tra le nuvole minacciose di un diluvio universale imminente ci fa stringere un po il cuore ; la Banda Fratelli viene alla luce splendidamente, con quella falsa ingenuità che lascia ben sperare a futuri prossimi e queste tracce - che sono volate via come la freccia indicatoria di un prossimo coming soon – vivono di una forte personalità artistica che mischia e completa il nostro bisogno assoluto di cose buone, appetibili, che tramutino i nostri stereo in juke-box dispenser per artisti e musiche intelligenti.
Previsioni metereologiche: un bel fulmine si sta abbattendo sulle scene alternative tricolori, okkio!
Voto: ◆◆◆◆◆
Label: Controrecords/New Model Label


 19:07
19:07
 Max Sannella
Max Sannella