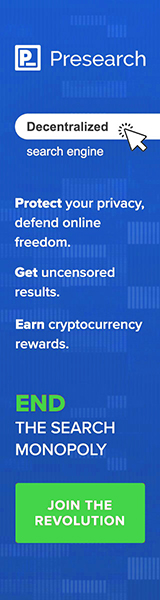Viene alla luce l’official work dei biellesi Invers, “Dal peggiore dei tuoi figli”, un altro tentacolo sonoro che si muove sulla scena emergente ed indipendente tricolore, e da quanto si sente sia ha la netta sensazione che la band sia consapevole dell’eredità pesantissima che il rock delle novità e del suo potere di “sverginare” immediatamente gli ascolti sia lontano ma ci si prova, e che ricreare le atmosfere alchemiche della formula vincente è solamente un miraggio concreto dal quale chiunque oramai è portato ad arrendersi se non addirittura prendere valigia e bastone e cambiare strada.
Ad ogni modo i nostri si muovono spigliati e con focoso incedere, giocano con un ritmo shuffleato e con una caratteristica Ottantiana che li vuole schizzati ed elettronici quel tanto che basta per far muovere corpo e mente oltre le briglie soft punkyes e le singolarità melodiche robotizzate che tanto piacciono ai cultori di un certo revivalismo pop di stampo teutonico; un disco di undici tracce abbastanza rievocativo alla Garbo “Qui fa sempre buio pesto”, la titletrack, “Buongiorno America”, un ascolto libero da intoppi e da quell’avant-gard saccente che oramai ha imparato il giochetto del come dissipare la noia defilata di un tempaggio obbligato, ma anche una stimolante rivisitazione del “Mio fratello è figlio unico” dell’oramai troppo strapazzato Rino Gaetano che fa tanto gioiellino e una altrettanto sfiziosa divagazione onirica wave-Mex fichissima che “becchetta” il numero nove della scaletta “La rivincita dell’humus”.
Un esordio di tutto rispetto, senza toccare magari le alte vette creative ma nemmeno “uno degli ultimi arrivati”, che si fa amico del lettore ottico, ammicca intelligenza e dichiarazione artistica più che solida e che – nolente o dolente – fa comunque quel passo decisivo ed impeccabile ad aprirsi alle nuove territorialità d’ascolto senza mai rinunciare alla propria integrità e al modo di intendere i sapori variegati del Signor Rock, sapori già “annusati” nel buon antipasto di “Ossigeno”.
Voto: ◆◆◆◇◇
Label: Vina Records 2012
Ad ogni modo i nostri si muovono spigliati e con focoso incedere, giocano con un ritmo shuffleato e con una caratteristica Ottantiana che li vuole schizzati ed elettronici quel tanto che basta per far muovere corpo e mente oltre le briglie soft punkyes e le singolarità melodiche robotizzate che tanto piacciono ai cultori di un certo revivalismo pop di stampo teutonico; un disco di undici tracce abbastanza rievocativo alla Garbo “Qui fa sempre buio pesto”, la titletrack, “Buongiorno America”, un ascolto libero da intoppi e da quell’avant-gard saccente che oramai ha imparato il giochetto del come dissipare la noia defilata di un tempaggio obbligato, ma anche una stimolante rivisitazione del “Mio fratello è figlio unico” dell’oramai troppo strapazzato Rino Gaetano che fa tanto gioiellino e una altrettanto sfiziosa divagazione onirica wave-Mex fichissima che “becchetta” il numero nove della scaletta “La rivincita dell’humus”.
Un esordio di tutto rispetto, senza toccare magari le alte vette creative ma nemmeno “uno degli ultimi arrivati”, che si fa amico del lettore ottico, ammicca intelligenza e dichiarazione artistica più che solida e che – nolente o dolente – fa comunque quel passo decisivo ed impeccabile ad aprirsi alle nuove territorialità d’ascolto senza mai rinunciare alla propria integrità e al modo di intendere i sapori variegati del Signor Rock, sapori già “annusati” nel buon antipasto di “Ossigeno”.
Voto: ◆◆◆◇◇
Label: Vina Records 2012


 17:07
17:07
 Max Sannella
Max Sannella





















.jpg)