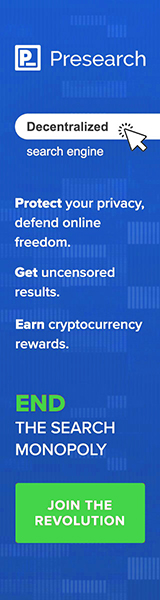Seneca
- “
Omnes feriunt, ultima necat” -
Seneca il Vecchio allude al tempo, il succedersi irreversibile delle ore. Ciascuna porta la sua pena, la sua gioia, la sua esperienza. L’ultima uccide. Una frase che, nelle sue varianti, spesso veniva incisa sulle meridiane, o sui quadranti degli orologi.
Il Tempo della vita, un concetto così vasto, straordinariamente descritto con una sintesi disarmante. Oggi, dopo “solo” poco più di due millenni, tre ragazzi, dalla Svizzera, rievocano il pensiero del Retore tagliandolo di netto, con sfrontatezza, per gettarne via una parte e conservarne solo la Fine: Ultima necat – “L’ultima uccide”. Loro sono i Ventura e ne fanno il titolo del terzo album full length, in studio.
"
About to Despair" introduce il disco con un accordo aperto di chitarra, un suono lontano e bagnato di riverbero, che mette in chiaro, fin dalle prime note, la distanza dai lavori precedenti. La band intraprende una strada indubbiamente più complessa, portando alla luce un amore incondizionato e già manifestato in precedenza per i
The God Machine. Si scivola verso "
Little Wolf", tra stratificazioni emotive e sonore profondamente articolate, perfette e fuori dal tempo. Il coinvolgimento è immediatamente totale e lo stupore è grande, come se il disco arrivasse da tutt’altro decennio e certamente non perché odora di vecchio, la ragione è che suona meravigliosamente. L’impatto è violento e la sensazione iniziale si consolida minuto dopo minuto, portando con sé il dolore, la poesia e l’esperienza, esattamente come Seneca Il Vecchio ha descritto il susseguirsi delle ore.
La sequenza dei brani sembra avere un ordine imprescindibile, un filo rosso lega ogni istante al successivo, dando l’impressione di ascoltare un continuum, dalla prima all’ultima traccia del disco. È come un viaggio d’introspezione pura, attraverso la sofferenza più intima che dilania in modo costante, chirurgico e raccontata da un canto che non esplode mai, contrapposto a suoni tesi, sovrapposizioni perfette e multiformi, dure quanto fragili, che trascinano spasmodicamente chi ascolta, verso uno spannung estenuante e mai definitivo. "
Nothing Else Mattered" allenta il nodo stretto da "
Little Wolf" e avvicina quasi con cinismo "
Body Language" e "
Intruder".
Slowdive,
Codeine e ancora
The God Machine, si annidano più o meno velatamente tra questi suoni, cuciti su strutture ritmiche quasi avant-rock e il risultato è stupefacente.
L’apice, il capolavoro di
Ultima Necat arriva con una spietatezza agghiacciante, dal linguaggio del corpo alla mutilazione: "
Amputee", soffoca. 11 minuti e 41 secondi di puro decadentismo letterario, visionario, disegnato ferocemente da un crescendo di angoscia, che fa leva sul convulso ripetersi di poche note. La speranza violentata per 6 minuti, poi la tregua apparente che trascina inesorabilmente verso l’oblio di un animo lacerato, fino alla fine del brano. "
Corinne" non lascia il tempo di rialzarsi, arriva cambiando registro, decisa, meravigliosamente ossessiva, suoni più secchi e pesanti, drumming serrato, come una reazione che trova la sua naturale conseguenza in "
Very Elephant Man". Una scomposizione ritmica degna degli
Shellac che lascia spazio, senza arretrare del tutto, a suoni marcatamente shoegaze. Una meraviglia che accompagna verso "
Exquisite and Subtle", l’ultimo solco del disco, una discesa in cui la tensione emotiva cede il passo a una tristezza talmente vasta da essere informe e tuttavia non del tutto rassegnata.
“Sottilmente” ferisce di più. Alla fine la percezione del vuoto è tangibile e l’istinto di ricominciare da capo è incredibilmente forte.
Atmosfere inaspettate. L’ultimo EP pubblicato dai Ventura nel 2010, lasciava presagire altri suoni e direzioni: “
It's Raining On One Of My Islands / Le Petit Chaperon Beige” – follow up di "
We Recruit", aveva addirittura richiamato “spontaneamente” e qui cito la band – “[...]
In case he would like to sing on them. And not only did he, but he did [...]” - l’attenzione di
David Yow [
Scratch Acid, The Jesus Lizard, Qui], con risultati assolutamente notevoli. Un cambiamento, quindi, non un’evoluzione, che va premiato senza alcuna esitazione. I Ventura sono riusciti ad esprimere arte, decadentismo, angoscia, emotività con una spontaneità disarmante, senza esser patetici o magniloquenti, senza risultare banali, semplicemente con umiltà, attraverso un’incredibile urgenza creativa. Masterpiece.
Voto:
◆◆◆◆◆
Label: Africantape & Vitesse Records.
 Alla terza prova i brianzoli Seditius continuano il loro percorso di avvicinamento al blues. Blues marcio e che è saturo di hardcore e sludge. O meglio, dovrebbe, forse, essere più sludge, diciamo, perchè così come si presenta con questo nuovo EP, ne esce una band grintosa e potente ma che ancora non ha trovato un suo suono, più che una sua forma. La forma è quella di un bluesaccio sguaiato e urlato, di un rock'n'roll garage paludoso, di un elettricità rock che ti spintona a dovere ma ancora non ti fa cadere dalla sedia, ancora non ti fa saltellare per la stanza contro i mobili, possibilmente sfasciando qualcosa. Ma questa anima distruttiva e nichilista è di certo li, da qualche parte (di sicuro si esplica nel modo più compiuto durante i loro live, soprattutto quelli all'estero!), ancora timidamente nascosta in un suono ancora troppo classico, dove i bassi pulsano ancora poco e le chitarre non sono ancora abbastanza sature e acuminate. Batteria e voce ci sono, ma anche loro devono sottostare a questo lo-fi che ne debilita un po' le spinte violente, le àncora a terra. In questo senso spaccava di più il precedente Carne da Macello come suono. Quindi possiamo definire questo Misplaced come un bel ripasso della tradizione (c'è anche un'organetto che razzola piacevolmente qua e là) nell'attesa che le due anime dei Seditius (quella più fangosa e hardcore e quella che fa l'occhiolino al blues) possano ricompattarsi in un qualcosa di più adeguatamente massiccio e ispirato, squassante e punk! E poi io in futuro ci butterei dentro anche qualcos'altro in italiano, alla fine gli episodi di questo tipo in Carne da Macello erano più che convincenti. L'EP è scaricabile gratuitamente dal bandcamp dell'etichetta.
Alla terza prova i brianzoli Seditius continuano il loro percorso di avvicinamento al blues. Blues marcio e che è saturo di hardcore e sludge. O meglio, dovrebbe, forse, essere più sludge, diciamo, perchè così come si presenta con questo nuovo EP, ne esce una band grintosa e potente ma che ancora non ha trovato un suo suono, più che una sua forma. La forma è quella di un bluesaccio sguaiato e urlato, di un rock'n'roll garage paludoso, di un elettricità rock che ti spintona a dovere ma ancora non ti fa cadere dalla sedia, ancora non ti fa saltellare per la stanza contro i mobili, possibilmente sfasciando qualcosa. Ma questa anima distruttiva e nichilista è di certo li, da qualche parte (di sicuro si esplica nel modo più compiuto durante i loro live, soprattutto quelli all'estero!), ancora timidamente nascosta in un suono ancora troppo classico, dove i bassi pulsano ancora poco e le chitarre non sono ancora abbastanza sature e acuminate. Batteria e voce ci sono, ma anche loro devono sottostare a questo lo-fi che ne debilita un po' le spinte violente, le àncora a terra. In questo senso spaccava di più il precedente Carne da Macello come suono. Quindi possiamo definire questo Misplaced come un bel ripasso della tradizione (c'è anche un'organetto che razzola piacevolmente qua e là) nell'attesa che le due anime dei Seditius (quella più fangosa e hardcore e quella che fa l'occhiolino al blues) possano ricompattarsi in un qualcosa di più adeguatamente massiccio e ispirato, squassante e punk! E poi io in futuro ci butterei dentro anche qualcos'altro in italiano, alla fine gli episodi di questo tipo in Carne da Macello erano più che convincenti. L'EP è scaricabile gratuitamente dal bandcamp dell'etichetta.

 15:58
15:58
 MUSICA PER DROGATI
MUSICA PER DROGATI


.jpg)