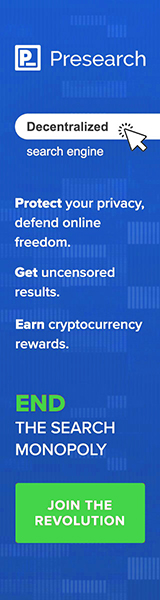C'è chi dice che la crisi crea
opportunità, e forse qualcuno ci crede davvero. Tipo i Deadburger,
band con una carriera ultradecennale che in un'era in cui non si
vendono più cd (ma da mò...) ne fa uscire ben tre. Un trittico di
album ognuno col suo bel titolo e la sua ambientazione sonora, pieno
di svariate collaborazioni (Emanuele Fiordellisi e Giulia Sarno da
Une Passante, Gabrielli, Benvegnù etc...) e votato alla
sperimentazione di atmosfere tanto variegate quanto unite da un
invisibile filo conduttore, uno stile coerente che emerge tanto nei
brani più rock quanto nelle preponderanti divagazioni elettroniche,
siano esse minimalmente psichedeliche o totalmente votate
all'avanguardia sonora.
Inizio il viaggio da Puro Nylon
100%, in cui l'incipit claustrofobico di “Madre”, basso e
batteria a dettare un ritmo lento ed ossessivo solcato da parole,
rumorismi elettronici, rade note di chitarra elettrica e violini,
nasconde la reale natura del disco: sono infatti le atmosfere
rarefatte e minimali le vere padrone, ben delineate dalle “Variazioni
Su Un Campione Di Erik Satie”che oscillano fra violini ed effetti
elettronici inquieti per lasciare spazio, al quarto assalto, anche
alla chitarra elettrica, ma sono soprattutto “Oltre” ed il suo
ideale seguito, “Ancora Più Oltre” a lasciare il segno.
Muovendosi lungo la stessa melodia la prima si regge quasi
esclusivamente su un giro di basso mellifluo ed avvolgente, la
seconda lascia spazio alla tromba di improvvisare lungo i tre minuti
del brano, una tromba capace di rapire già nella precedente “In
Ogni Dove”, notturna suite dal mood raffinato e rilassante. Come
una mosca bianca si inserisce in tutto questo “Obsoleto Blues”,
mutevole brano dal fortissimo groove dove basso (ora “liscio” ora
graniticamente distorto) e batteria dettano il ritmo mentre alla
chitarra è lasciato il compito di creare psichedeliche visioni
sonore su quel tappeto, un tappeto che da metà brano si fa quasi
tribale in una folle corsa sui fusti da parte della batteria.
Microonde Vibroplettri segue a
ruota nell'ordine di ascolto, e qui il discorso si fa complicato. I
Deadburger, nella persona di Vittorio Nistri per i primi brani e di
Alessandro Casini nella seconda parte, danno infatti libero sfogo
alla sperimentazione perlopiù elettronica, piazzando qualche buon
colpo con la liquidità minimal-psichedelica dell'orientaleggiante
“Il Dentista Di Tangeri” e con i distortissimi incroci
chitarristici di “Cuore Di Rana” (che sanno molto di Butthole
Surfers) ma buttandosi per il resto sui rumorismi troppo fini a sé
stessi di “La Mia Vita Dentro Il Forno A Microonde” e “Magnetron”
o sul ritmo ripetitivo ed estenuante di “Strategia Del Topo”. Va
un po' meglio con la struttura delirante di “Dr. Quatermass, I
Presume” e con la dilatazione da trip di “Micronauta”, ma
quando arriva la chiusura col ritorno di basso e chitarre a
tratteggiare un percorso ripetitivo ma tutto sommato piacevole in
“Arando I Campi Di Vetro” le somme che tiro non sono positive
quanto nel disco precedente.
La Fisica Delle Nuvole, parte
conclusiva del trittico nonché episodio che dà il titolo al'intera
produzione, ritorna su atmosfere meno criptiche: fra la new wave
oscura e mediorentaleggiante di “Amber”, il groove rock di
“Bruciando Il Piccolo Padre” ed il funky alla lunga estenuante di
“Deposito 423” questa parte del progetto rivela il lato più
tradizionalmente rock della band, anche se non mancano episodi più
rarefatti fra cui già l'iniziale title track, in cui la levità dei
suoni viene amplificata dal testo, parlato, rubato a Kurt Vonnegut, o
in “Wormhole”, dove il tappeto di basso viene solcato da tromba e
violini e, brevemente, anche da un duetto di voci maschile e
femminile ben congegnato. Il vocalist Simone Tilli esce qui in
maniera preponderante, sfoggiando un tono perlopiù greve che ben si
adatta alle varie atmosfere, anche se certe forzature metriche in
“Bruciando Il Piccolo Padre” sanno di esercizio di stile un po'
fine a sé stesso, almeno finchè il groove del pezzo non riesce a
sopperire ad un inizio un po' balbettante. C'è spazio anche per
brani dal ritmo quasi tribale come “Cose Che Si Rompono” e “Il
Mare E' Scomparso”, trascinati dalla fantasia del batterista. Il
mood è meno coinvolgente rispetto al primo disco, ma la varietà di
atmosfere riesce comunque ad elevare anche questa porzione del lavoro
a buoni livelli ed a concludere degnamente l'intero viaggio.
E' difficile valutare un'opera
così variegata e monumentale nelle sue dimensioni, un'opera che non
può essere scissa fra l'altro dalla sua componente fisica: dalla
cover, realizzata da Paolo Bacilieri, all'albo di 64 pagine a cui lo
stesso artista ha contribuito. Un albo essenziale per comprendere
meglio tutto il lavoro, che permette di scoprire retroscena legati
agli spettacoli teatrali di cui questi brani sono stati “colonna
sonora” (registrati e in alcuni casi modificati apposta per
l'occasione nonostante ripercorrano un arco temporale di 10 anni)
oltre a gustosi inserti di cultura spicciola sempre legati a doppio
filo ai titoli ed agli argomenti, tutti riuniti sotto la dicitura
“Poor Robot's Almanack”, personaggio quest'ultimo che può essere
definito come una mascotte dell'intero lavoro. Per tutti questi
piccoli e grandi dettagli non si può non consigliare la nuova fatica
dei Deadburger, una formazione in continua evoluzione che con La
Fisica Delle Nuvole riesce a delineare chiaramente la propria natura
multimediale ed artisticamente bulimica.
Voto: ◆◆◆◆◇
Label: Snowdonia / Goodfellas


 07:22
07:22
 FickyIZ
FickyIZ