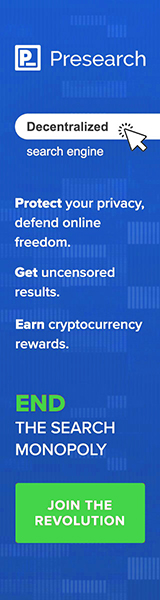Ottime nuove dall’emisfero HC melodico tricolore, dalla bella Vigevano i ribelli GPL sono di nuovo in giro per scalmanare folle e coni stereo come si conviene, e questo “Phoenix” è l’immediatezza della loro proposta che prende avvio nel 1999 e, dopo una sconbussolatina di idee e line-up, arriva ai nostri giorni sempre feroce, fresca e con i denti aguzzi come poche; cinque tracce al fulmicotone che della forte paternità Offspring ne sono consapevoli, quella energia influenzata – specie nelle giugulari d’insieme – che non fa difetto nessuno, la band, un quartetto anthemico e stradaiolo, è micidialmente autonoma nei passaggi, nella spinta guerriera e nel consolidamento di un genere estremo che non demorde un millimetro della sua storia.
Tutto batte forte, tutto scintilla e si sgola in un lavoro “a batteria” che non passa inosservato, come non passano inosservate nemmeno le particolarità – nel nervo scattante della tracklist – che guardano in terra a stelle e strisce, specie nei pandemoni oltraggiosi e corali in cui gravitano band come Good Riddance, Rise Again, tutte detonazioni amplificate che quasi quasi fanno “mitologia” ancor prima di deporre le armi del suono, i proiettili delle parole; una prova discografica della quale parlarci sopra può rendere vana la vera portata dei tracciati sonici, tanto vale infilare il cerchietto di plastica “bollente” nella fessura stereo e lasciare che i miasmi, le verità, le fogne e la non indulgenza distorta prendano libertà e strada propria, incarnandosi in un pogo “invalidante” favoloso e schizzato dalle atmosfere antagoniste e libertarie che ogni goccia di sudore trasmette.
Cinque tracce di vita, tutte da ascoltare e inneggiare come fossero tutto ed il contrario di tutto, percorsi minati che non divagano in derive o inciampi, dritte e robuste come frustate su cosce scoperte che iniziano con l’ansia elettrica di “Song of liberty” e finiscono nei retaggi corali metallici da curva sud di “Letters to myself”, e nel mezzo? Alta tensione e strage di sali minerali!
Bollino rosso di goduria assicurata.
Voto: ◆◆◆◇◇
Label: Autoproduzione
Tutto batte forte, tutto scintilla e si sgola in un lavoro “a batteria” che non passa inosservato, come non passano inosservate nemmeno le particolarità – nel nervo scattante della tracklist – che guardano in terra a stelle e strisce, specie nei pandemoni oltraggiosi e corali in cui gravitano band come Good Riddance, Rise Again, tutte detonazioni amplificate che quasi quasi fanno “mitologia” ancor prima di deporre le armi del suono, i proiettili delle parole; una prova discografica della quale parlarci sopra può rendere vana la vera portata dei tracciati sonici, tanto vale infilare il cerchietto di plastica “bollente” nella fessura stereo e lasciare che i miasmi, le verità, le fogne e la non indulgenza distorta prendano libertà e strada propria, incarnandosi in un pogo “invalidante” favoloso e schizzato dalle atmosfere antagoniste e libertarie che ogni goccia di sudore trasmette.
Cinque tracce di vita, tutte da ascoltare e inneggiare come fossero tutto ed il contrario di tutto, percorsi minati che non divagano in derive o inciampi, dritte e robuste come frustate su cosce scoperte che iniziano con l’ansia elettrica di “Song of liberty” e finiscono nei retaggi corali metallici da curva sud di “Letters to myself”, e nel mezzo? Alta tensione e strage di sali minerali!
Bollino rosso di goduria assicurata.
Voto: ◆◆◆◇◇
Label: Autoproduzione


 12:12
12:12
 Max Sannella
Max Sannella

.jpg)









.jpg)